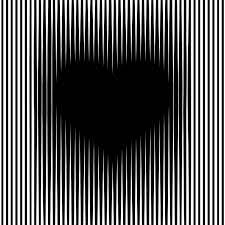Nel deserto

Varcai la soglia della facoltà di lettere classiche inciampando. Il contenuto della mia borsa si rovesciò ovunque, tra le risatine al gloss delle mie colleghe e le Superga alla moda dei maschi. Recuperando il portafogli, ne sgusciò fuori la mia carta d’identità: “Cristo, che guaio passato che sono”, bestemmiai paonazza davanti a quella foto del cazzo.
“Piacere, Valerio”, disse divertito un ragazzo inginocchiandosi accanto a me per ramazzare i mille oggetti che avevo eruttato. “Claudia”, risposi, chiedendomi se il mio imbarazzo puzzasse e se i miei capelli fossero sopravvissuti alla caduta.
Entrambi lì per la prima lezione di letteratura latina, ci incamminammo insieme verso l’aula magna (“Ti accompagno io”, aveva detto), chiedendoci, con arie da filologi di quartiere, se ci avrebbe mangiato per davvero. Io gli occhi bassi, lui salutando gente in ogni direzione.
Il professor Paoletta si aprì un varco tra i nostri schiamazzi con un ingresso magistrale: in corsa, scaraventò alcuni libri sulla scrivania e, schiena all’enorme distesa di ardesia che lo incorniciava, guardò gli almeno trecento studenti che già pendevano dalle sue labbra. Il silenzio si fece d’oro. Io e Valerio ci scambiammo uno sguardo di universitaria complicità.
“La brezza del deserto ha soffiato sul mio cuore e v’è rimasto il deserto. Non c’è brezza, né luna che possa farvi scendere la sua rugiada”, principiò. Nessun caffè all’alba, nessun allenamento. Paoletta ci trascinò dritto al centro della maratona che furono le sue seducenti e difficilissime lezioni.
Vidi Valerio avvampare e tremare accanto a me, attraversato da una folgore. Istintivamente prese la mia mano e, senza girarsi, disse piano: “Lo amerò per sempre”. La mia penna rotolò emozionata tra i gradini dei banchi, ma aveva fatto in tempo a trascrivere quei versi che – seppi poi – appartenevano ad un anonimo egizio di circa tremila anni prima del cristo che nominavo troppo spesso.
Strappai con cura il rettangolo di carta che li cullava e lo riposi, origami da portafogli, in quel documento di riconoscimento che pensavo non mi ritraesse. Spinta da non so quale vento, riafferrai la mano di Valerio.
Lo guardai con fermezza negli occhi e, coraggio in faretra, gli risposi: “Anch’io”.
Sono passati due anni da quando io e Valerio ci siamo piovuti addosso nei corridoi della Facoltà di Lettere. Abbiamo riso a lungo della mia memorabile caduta e della sua aria da maestrino divertito ogni volta che, tra una lezione e l’altra, ci incontravamo per un caffè all’angolo.
“Dai, Claudia, fammi rivedere quella foto!”, mi diceva sempre. E io, senza sapermi immergere nella catramosa malinconia del suo sguardo, fingevo di stringere forte il mio serissimo zaino bianco e nero. Additavo Valerio come mi avevano insegnato a fare con i borseggiatori sull’autobus e distribuivo a tutti sguaiate grida di aiuto per barattare una fettina della sua sicurezza con un assaggio della mia vergogna.
Mi piaceva? Moltissimo, si. Lui, però, sembrava sottrarsi continuamente. Professava una fede assoluta nel potere taumaturgico della letteratura, ma non ne beneficiava, non ne gioiva, come se tra la sua identità e l’erotica dei libri si fosse praticata una crepa che nessuno scampolo di realtà avrebbe mai potuto rabberciare. Appariva sempre più rinchiuso nel caveau del suo silenzio. E, per quanto mi industriassi nel forzarne la serratura, non riuscivo a capire che diavolo gli passasse per la testa.
“Cazzo, Valerio, hai fatto presto!”, lo apostrofai quasi indignata all’uscita dell’aula in cui il Prof. Paoletta teneva gli esami di Latino 2. Non lo accompagnavo mai (era categorico su questo punto), ma quella volta decisi di appostarmi nel lungo corridoio di fregi e marmo.
Valerio, pallido, trasalì. Nel tentativo di dissimulare velocemente il suo disagio, scelse di sorridermi con slancio, una trovata utile solo a calare tra noi un velo di spessa diffidenza.
“Si”, rispose, “mi ha fatto solo due domande, ho preso ventisette”.
“Che culo”, gli rinfacciai incredula. “A me ne ha fatte più del doppio e ho beccato un ventiquattro!”
“Coraggio”, aggiunse, “l’importante è passare…”. Nel dirlo, fissò il lussuoso pavimento a scacchi.
Quegli occhi scuri e bovini sembrarono all’improvviso fuori dalla mia portata. Cercai allora un contatto periferico, annaspando verso la sua mano come avevo fatto il giorno in cui Paoletta ci aveva presi al laccio della poetica egizia, ma ottenni solo una scrollata e un rancoroso borbottio. Capii, allora, che dovevo lasciarlo in pace.
E così feci. Per quel giorno e poi, di certo, troppo a lungo.
#3 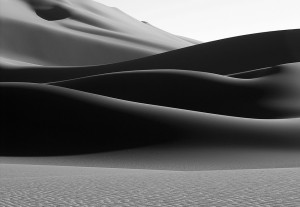 Il giorno della laurea si avvicinava come un maglio allo stomaco, portando con sé un carico d’ansia che mal sopportavo. Non erano stati anni dolci per me. Rincorrevo i tempi del sistema con grande riluttanza e sentivo addosso il tanfo di una mentalità ristretta che, in ambito accademico, non smetteva di nausearmi. La mancanza atavica di strutture, personale e fondi, figlia di tagli finanziari chirurgicamente apportati per modellare il Frankenstein della nostra istruzione, pesava ogni giorno come una colpa su troppi di noi.
Il giorno della laurea si avvicinava come un maglio allo stomaco, portando con sé un carico d’ansia che mal sopportavo. Non erano stati anni dolci per me. Rincorrevo i tempi del sistema con grande riluttanza e sentivo addosso il tanfo di una mentalità ristretta che, in ambito accademico, non smetteva di nausearmi. La mancanza atavica di strutture, personale e fondi, figlia di tagli finanziari chirurgicamente apportati per modellare il Frankenstein della nostra istruzione, pesava ogni giorno come una colpa su troppi di noi.
Non era nostra la colpa, no. Ma in questo mondo di competitor e di precariato, dove il bisogno è ridotto a puro commercio e gli ideali a nugae, ci vuole molto poco per sentire di non aver diritto a esistere. Trovavo sempre qualcuno che “ce l’aveva fatta in tempo”, “si era laureato studiando poco”, “aveva trovato immediatamente lavoro”, “si era realizzato subito dopo l’università”.
Erano mosche bianche, ne ero sicura, ma continuavano a ronzarmi intorno fastidiose, pericolose. Pensavo di poterle tenere a bada con la paletta della mia determinazione, ma in realtà sentivo l’infezione propagarsi nel mio sistema immunitario e fiaccare ogni mia difesa emotiva. Lottavo ogni giorno contro la convinzione di essere una merda solo perché ero più lenta o meno intuitiva. E l’erotica dell’insegnamento del Prof. Paoletta, che all’inizio avevo classificato come pura rivoluzione, ora giaceva in archivio alla voce “giochi per bambini”.
Valerio, intanto, si faceva vedere sempre meno. Avvistamenti non confermati lo davano prossimo alla laurea proprio con Paoletta relatore, il suo mito, ma di lui non sapevo praticamente più nulla. Avrei voluto parlargli, chiedergli come se la passasse. Invece, ogni volta che mi sembrava di scorgerlo nel brulicare dei corridoi, sgusciava via prima che potessi anche solo arrivare a sfiorargli le mani.
Una mattina di giugno, annunciata dal colorarsi delle albicocche, mi infilai in un’aula vuota al terzo piano, in cerca di un posto fresco e solitario in cui studiare.
“VALERIO!”, urlai con tutta la voce che trovai. Era lì, in piedi sul davanzale dell’alto finestrone, a fissare privo di luce interiore il cortile interno. Del tutto ignara, un’umanità robotica inseguiva imperterrita il proprio nulla.
#4
Valerio non diede segno di avermi sentito. Non si mosse. Era pietra nei suoi pensieri inconoscibili e acqua in un’espressione vuota, asciutta, lontana dalla tranquillità tanto quanto dalla disperazione. Mi si indurì il fiato. Cercare aiuto? Correre il rischio di lasciarlo solo? Non c’era tempo. E anche lo spazio prese a rimpicciolirsi così vertiginosamente da procurarmi conati di vomito.
“Valerio…ti prego”, dissi sforzandomi di non piangere. “Sono io, Claudia. Dai, scendi, mi stai spaventando”.
Si girò lentamente, come una grossa testuggine. Sul suo carapace sembravano trascorsi millenni, così come tra lui e il ragazzo che avevo conosciuto. Mi guardò senza vedermi davvero. Provai a fare un passo nella sua direzione e allungai la mano destra, lasciando cadere pesantemente lo zaino rigonfio di libri ai miei piedi. Il tonfo lo riscosse e vidi un accenno di presenza, di ritorno.
“Claudia…ho fatto un casino”, disse disperato. Si era perduto. Mi sembrò di nuotare nella polvere dell’universo, pietrisco di vite che non percepivo. La sua voce era una specie di ululato dimesso, i capelli si mostravano rancidi, gli abiti perdonavano una magrezza che non ricordavo.
“Valerio, scendi”, lo supplicai. Qualunque cosa fosse, volevo solo vedere le sue ginocchia e i suoi piedi conquistare la sicurezza del pavimento.
“Non capisci! Io non posso tornare a casa!”, gridò.
“Va bene, non devi tornarci ora! Dai, parliamo io e te, ok? Dammi la mano, ti prego”, dissi provando a mantenere il controllo.
Mentre mi allungavo verso di lui, qualcuno entrò sbattendo la porta. Il prof. Paoletta, senza volerlo, non riusciva a fare a meno degli ingressi teatrali. Gli vidi il sangue raggrumarsi nelle vene e quel viso ogivale, normalmente aspro e respingente, trascolorò assumendo un’aria di drammatica comprensione.
“Ragazzi, calmiamoci tutti”, disse richiudendo piano. “Tu, lassù, come ti chiami?”. Fu una domanda che mi allarmò moltissimo: Valerio non avrebbe dovuto laurearsi con lui? Come mai Paoletta non ricordava chi fosse?
“Si chiama Valerio, professore”, interloquii. “Adesso scende. Vero?” e guardai dolcemente il mio amico. Capii tutto. Purtroppo troppo tardi, solo quando sensi di colpa e inadeguatezza lo avevano già fatto a pezzi.
Paoletta rincarò: “Coraggio, Valerio, sistemeremo tutto”.
“E come?! Io…gli esami…non riesco più a farli, non riesco più a respirare. E come posso, ora, venire fuori da tutta questa merda, dalle bugie che ho raccontato ogni giorno?”
Paoletta si rabbuiò. Era un vecchio insegnante di letteratura che teneva ai ragazzi. Con energia diceva loro di studiare perché l’umanità meritasse il titolo di specie evoluta, ma sapeva anche leggere la realtà oltre le parole, i versi, i voti. Capiva che per quanto salvifico potesse essere un racconto o totalizzante la perfezione nel composto frantume dei distici elegiaci, nessuno in fondo aveva abbastanza amore per guardare dentro quella fragilità che ora Valerio incarnava suo malgrado.
Nessuno voleva davvero dare spazio ad un ragazzo disperato per non essere riuscito a stare al passo, un ragazzo così certo dell’egemonia dei Numeri sulla Vita al punto da darsi in pasto alla morte. Lo spirito della nostra società, davanti a queste decisioni, è già un appalto della fine.
Vince, così, un’idea di merito ritagliata su un’arcaica concezione di darwinismo.
La realtà si infrange contro pile e pile di analisi spicce.
Il vuoto si espande erodendo quei pochi tavolieri di consapevolezza che ancora resistono.
E resta l’unicità di un ragazzo, già oltre l’ideazione suicidaria, sul precipizio di un’istituzione ormai decrepita e di un vivere senza orizzonti di senso.
“Credimi, niente di tutto questo vale la tua vita”, principiò Paoletta indicando i grossi banchi di mogano tarlato. “L’imputato non sei tu. Sono io. O almeno tutto ciò che rappresento”.
Raggiunto dal sole estivo, ormai alto nella grande stanza vuota, sembrava stanchissimo.
“Avevo il dovere di capire dove fossi per vederti, capirti, non per spiarti. E di certo non per controllarti. Tutti lo avevamo. Vi guardiamo dall’alto della nostra sopravvalutata esperienza, pensando tronfi di essere sempre nel giusto solo perché adulti, solo perché insegnanti. Una nuova forma di suprematismo che spiana ogni cuspide di diversità. E non ci sforziamo mai di leggere i vostri passi, di capire quale sentiero stiate tracciando. Non vediamo verso quale abisso vi spingiamo. Non è colpa tua, giovane amico. E’ mia. Nostra.”
Si abbandonò su una sedia e si mise la testa tra le mani. Io lo sbirciavo mentre tenevo sotto rigido controllo ogni movimento di Valerio che rimaneva lì, paralizzato nella sua angoscia. Favorita, però, dal discorso del professore, annullavo centimetro dopo centimetro la distanza tra me e lui.
All’improvviso Paoletta alzò lo sguardo e disse qualcosa che prese corpo dalla sua voce commossa e vibrante. Fu come vedere un ricordo fumoso diventare di carne: un golem venuto dal passato attraversava l’oggi di tre persone le cui vite si erano aggrovigliate per un’inattesa declinazione dell’effetto farfalla.
“Ricordi? La brezza del deserto ha soffiato sul mio cuore e v’è rimasto il deserto. A lezione non ho mai spiegato che quel poeta egizio ha lasciato altri versi meravigliosi, pieni di sabbie fertili e acque rutilanti come gli scudi dei suoi dei. E’ sopravvissuto al suo deserto. Possiamo riuscirci tutti”.
Rievocai allora un Valerio ingentilito e toccato nel profondo, il ragazzo che tremante aveva preso la mia mano dichiarando amore eterno alla Bellezza.
Stavolta, non esitai. Non gli diedi il tempo di accorgersi che ormai ero vicinissima a lui. Gli afferrai la mano scarna e sofferente, la tenni stretta nella mia e lo tirai giù, pronta a placcarlo o a rompergli un braccio se avesse opposto resistenza.
Ma non ce ne fu bisogno. Lo presi con me, lo strappai al davanzale e, mentre Paoletta si rimetteva in piedi visibilmente sollevato, io e Valerio ci abbracciammo come non ci era mai riuscito di fare. Valerio si fece cullare a lungo dalla promessa di aiuto che io e il professore rappresentavamo per lui e pianse, finalmente, quel dolore non confessato che aveva ridotto ad un lumicino i suoi anni migliori.
Non disse una sola parola e, del resto, non era necessario.
Le nostre mani erano intrecciate, la paura ormai dispersa. Il coraggio, ancora in faretra, stavolta l’avevamo trovato insieme.
Miriam Corongiu